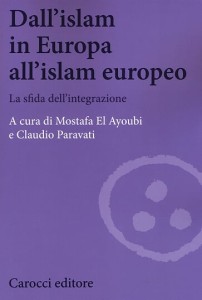Lo spinoso tema del rapporto tra Europa e religione islamica è ai nostri giorni oggetto di ampi dibattiti nel mondo accademico italiano e straniero. Antropologi, sociologi, islamisti, storici, filosofi tentano di comprendere al meglio il fenomeno dell’Islam in Europa attraverso gli strumenti che il proprio campo di studi fornisce e ritiene adeguati allo scopo. La tematica è in effetti di ampio respiro e coinvolge diverse branche delle scienze umane e politiche, ognuna rivelandosi capace di dare un contributo dalla propria prospettiva.
Il valore di un testo come Dall’Islam in Europa all’Islam europeo. La sfida dell’integrazione (Carocci, 2018), è invece insito nella convinzione che tali prospettive vadano incrociate, che solo il dialogo, il confronto tra diversi studiosi di materie differenti può fornire al lettore una visione d’insieme che permette quantomeno di comprendere la difficoltà del tema trattato. I quattordici articoli di cui è composto questo testo sono agili approfondimenti da parte di esponenti del mondo accademico, della carta stampata, e del dialogo interculturale, curati da Mostafa el Ayoubi e Claudio Paravati, entrambi molto attivi nelle pubblicazioni intorno al religioso nella società contemporanea.
Le riflessioni contenute nel testo partono quindi dal medesimo argomento, quello della possibilità di un Islam europeo, tentando di sfuggire alle tante, troppo semplificazioni spesso veicolate da giornalisti e studiosi poco preparati e decisamente faziosi:
«L’intento di questa riflessione, a più mani, è quello di offrire al pubblico chiavi di lettura diversificate su un argomento complesso e sensibile quale è il rapporto tra l’Europa e “i suoi musulmani”. Tutti i contributi di questo volume convergono verso un comune obiettivo, quello di presentare ai lettori una narrazione che non è sempre reperibile nella letteratura politica mainstream» (El Ayoubi, Paravati, 2018: 12).
È un obiettivo che può dirsi ampiamente raggiunto: i contributi forniscono infatti al lettore un quadro generale sulle nuove sfide dell’integrazione che l’Europa ha il dovere di affrontare, conscia dell’impossibilità di rimandare ulteriormente una presenza religiosa che è ormai parte costitutiva delle nostre società.
 Quale Islam europeo? Modelli di integrazione a confronto
Quale Islam europeo? Modelli di integrazione a confronto
La struttura del testo ha il pregio di riunire le opinioni dei diversi esperti, divenendo in alcuni casi quasi un gioco di rimandi che non può che essere positivo e stimolante alla discussione intorno al tema centrale. Indagini sociologiche, dati precisi sulle minoranze religiose, approfondimenti storici sulle relazioni tra mondo arabo e europeo si rivelano sia unità concluse in se stesse, sia riflessioni che danno al lettore la possibilità di avere una visione globale del tema sicuramente soddisfacente. Particolarmente interessanti sono quindi le considerazioni intorno (1) ai diversi modelli di integrazione, (2) alla reale conoscenza della religione islamica da parte della società europea e (3) ai simboli religiosi terreno di furiosi scontri ideologici (come, ad esempio, la complessa questione intorno al velo delle donne): sono questi temi che ritornano nei diversi articoli che permettono al lettore di seguire un filo rosso che rende il testo compatto, evitando così una miscellanea poco fruibile ai non specialisti.
Sulle diverse proposte di integrazione sono principalmente gli articoli di Ambrosini, Allievi e Bein Ricco quelli più interessanti e completi nel mostrare le strategie dei governi nazionali di fronte al pressante problema delle comunità islamiche che richiedono un riconoscimento formale e precisi diritti nelle nazioni di cui aspirano a diventare cittadini.
In primis, gli autori convergono che la generale espressione “integrazione” è insufficiente a spiegare la complessità dei modelli di integrazione. Occorre invece un approfondimento terminologico che permetta di distinguere tra modello assimilativo, modello pluralista e una nuova accezione, più ristretta, di “integrazione”, intesa come processo dinamico.
Il modello assimilativo, sostenuto dalle politiche francesi, ha mostrato diversi limiti: la «pressione per l’abbandono o la privatizzazione di peculiarità culturali, linguistiche e religiose» (Ambrosini: 50), a fronte di una naturalizzazione in tempi brevi, è sembrata a molti inaccettabile, così come almeno parzialmente fallimentare potrebbe essere definito il modello multiculturalista o plurale in vigore nel Regno Unito e nel Benelux, dove la convivenza tra culture diverse è in realtà troppo spesso reciproca diffidenza, in quella che è «una forma di cattivo pluralismo, un pluralismo senza confronto di comunità chiuse in se stesse come tanti ghetti, indifferenti le une verso le altre o peggio tra loro ostili» (Bein Ricco: 67).
Di fronte ai limiti di questi modelli, l’integrazione come processo dinamico si configura come possibile soluzione percorribile: rispettosa delle differenze, aperto a prospettive multidimensionali, attento alle realtà locali e disposto anche ad arrestarsi di fronte ad alcune aree sensibili. Modello di integrazione che andrebbe a vantaggio di una politica sostenitrice del pluralismo attivo, in cui lo Stato si presenta come soggetto promotore dello scambio e del dialogo religioso e culturale tra le diverse realtà. Non più quindi una falsa laicità che pretende di annullare la dimensione pubblica del religioso (visione molto ingenua, specialmente nel caso dell’Islam), ma una «laicità per addizione» (secondo un espressione usata da Paolo Naso), che «non esclude, come nel contesto francese, le differenze identitarie dallo spazio pubblico, anzi fa di quest’ultimo quel luogo affollato di presenze culturali e religiose di vario tipo che interagiscono tra loro, si incontrano e anche si scontrano, arricchendo il dibattito della società civile» (Bein Ricco: 67). Uno Stato che si erge pertanto come arbitro e presidio del pluralismo, con un ruolo attivo nel confronto tra le diverse parti della società.
I risultati di una tale impostazione potrebbero essere innanzitutto il diminuire dei fenomeni di isolamento e ghettizzazione e, parallelamente, l’inizio della costruzione di quell’Islam europeo che rappresenterebbe un importante passo avanti per le relazioni tra le comunità musulmane e il continente europeo. Come ben descritto dal sociologo Hannachi, «l’Europa è un’opportunità per il mondo islamico perché l’Islam europeo potrebbe essere il nuovo volto di questa religione costretta ad adeguarsi alla modernità e a convivere con la democrazia, la laicità e i diritti umani» (Hannachi: 101). In definitiva, occorre superare i modelli fallimentari promossi da buona parte delle nazioni europee e promuovere una nuova idea di integrazione, indispensabile premessa per la costituzione di una società plurale, ma unità dai più alti valori della democrazia e dei diritti umani:
«L’assimilazionismo e il multiculturalismo, intesi come modello di integrazione, sono alla base dell’emergere della sottocultura della radicalizzazione che alimenta il terrorismo, il quale a sua volta alimenta la diffidenza e l’odio nei confronti dei cittadini di fede o di cultura islamica che vivono in Europa. Occorre adottare un modello inclusivo che faccia sentire questi cittadini parte integrante della società in cui vivono, avendo a cuore la sua stabilità. Un modello che metta in relazione costruttiva loro e la società che li ha accolti, attraverso la valorizzazione dei rispettivi diritti e doveri, ha molta probabilità di favorire la convivenza e la pace sociale rispetto al modello muscoloso della sicurezza» (El Ayoubi: 146).
 Il sapere come antidoto all’intolleranza religiosa
Il sapere come antidoto all’intolleranza religiosa
Un altro tema rilevante, che assume soprattutto ai nostri giorni un’importanza cruciale, è la modalità attraverso cui la religione islamica viene rappresentata dai media. La lettura degli articoli di Cadeddu, Naso e Moual permette un quadro d’insieme sulla situazione italiana in cui si evince che alla costante volontà dei governi di costruire un campo di confronto non corrisponde invece un positivo sentire comune nella popolazione verso il mondo musulmano. La diffidenza verso l’altro, comprensibile per certi versi, è purtroppo sfociata in una palese e violenta ostilità che punta a distruggere qualsiasi ponte possibile tra culture diverse. I dinamitardi, tuttavia, sono facilmente riconoscibili: modestissimi “giornalisti” [1], esperti dell’ultima ora, autori di instant-book sul mondo musulmano frutto di appassionate ricerche durate quattro settimane, politici incompetenti e (s)velatamente razzisti.
Ancora più desolante è constatare come, in alcune trasmissioni di approfondimento, vengano scelti rappresentanti del mondo musulmano. La barba lunga, il copricapo tipico, la lunga tunica bianca, l’italiano o inglese parlato in maniera stentata, le posizioni spesso retrograde e in totale contrasto con la modernità europea: un campionario di pregiudizi volto a ribadire un’assoluta impossibilità di cambiamento da parte dell’ «homo islamicus» (Moual: 105).
L’Islam è quindi rappresentato come religione monolitica e immutabile, incapace, o semplicemente contraria a qualsiasi cambiamento e compromesso. È un Islam in fin dei conti semplice, che mostra quello che il mainstream giornalistico gli richiede: inflessibilità, intolleranza e odio viscerale per i “crociati”. Alla luce di queste considerazioni, lo sconforto provato da Moual è più che mai lecito:
«A questo punto ci si chiede: perché dobbiamo meritarci un’informazione così mediocre? Perché in una società multietnica come la nostra i suoi intellettuali e le seconde generazioni, che occupano anche ruoli di primo piano, non sono altrettanto protagonisti anche nella comunicazione? Un mondo dei media che ci illumini su scenari a noi sconosciuti. Un’informazione che sia di prima mano e non per sentito dire» (Moual: 107).
Occorre dunque pensare a come poter sfuggire alla banalità di certa stampa e di un certo tipo di informazione. Un aiuto in proposito viene dato dalla lettura dell’articolo della Cadeddu che, partendo dai dubbi di Moual, indaga quali possano essere le soluzioni all’ignoranza sui temi religiosi che impedisce di individuare un corretto modello di integrazione, anche a causa di un’opinione pubblica avvelenata di fronte ai temi dell’accoglienza. La soluzione prospettata dalla ricercatrice dello FSCIRE [2] è innovativa e interessante, e merita di essere discussa più ampiamente:
«La conoscenza dell’esperienza religiosa, delle dottrine, dei testi, delle correnti di pensiero e delle culture che a essa sono legate è uno degli strumenti più efficaci per sostenere accoglienza e integrazione in una prospettiva di lungo periodo» (Cadeddu: 58).
L’incapacità dell’Unione Europea di trovare una soluzione a medio-lungo termine sull’integrazione delle minoranze rivela drammaticamente come la carenza di conoscenze e competenze in ambito religioso non permettano alcun tipo di modello che non sia quello puramente emergenziale, spesso derivante da lunghi bracci di ferro tra le diverse nazioni europee.
La religione è stata vista da alcuni governi europei (si pensi al Belgio e alla Francia) come elemento da reprimere nel suo spazio pubblico, ma la “rivincita di Dio” [3] non si è fatta attendere, svelando una società che del religioso ha ancora bisogno, trovando in essa una componente fondamentale per la propria esistenza. Da queste considerazioni deriva che invece di sopprimere questa componente religiosa, si potrebbe tentare un approccio differente, che ne valorizzi l’esigenza con la prospettiva di formare i cittadini a conoscere le diverse realtà (religioni abramitiche, buddhismo e così via): l’incontro con le altre culture e religioni deve avvenire già a livello scolastico (non limitandosi all’ora di religione cattolica) e non essere più un sapere elitario limitato solo ai dottorandi e agli studiosi delle facoltà teologiche. Solo in questo modo anche il cittadino potrà avere, almeno parzialmente, gli strumenti critici necessari per rilevare l’inconsistenza «dei mezzi di informazione mainstream, che non migliorano la qualità e la quantità della conoscenza delle religioni per mancata volontà o per la banale difficoltà di giornalisti e autori ad accedere a un livello non superficiale di informazioni e strumenti di conoscenza».
 Il velo islamico tra islamofobia e academically correct
Il velo islamico tra islamofobia e academically correct
Un ultimo punto che potrebbe essere interessante dibattere riguarda l’annosa questione del velo per le donne musulmane. È ben noto come il velo rappresenti per alcuni Stati un simbolo di arretratezza religiosa da combattere attraverso leggi ad hoc [4], mentre altrove esso viene vissuto come semplice elemento culturale. Tornando al testo, sono i contributi di Cardini e della Iannucci ad affrontare il problema portando approcci differenti e approdando tuttavia a conclusioni simili. L’articolo di Cardini è in realtà un encomio di Chaimaa, giovane scrittrice [5] e studentessa musulmana, orgogliosa di portare lo hijab:
«Quanto al hijab, al velo che copre i capelli e il collo, Chaimaa lo ritiene una forma di libertà di esprimere la propria sostanza identitaria, senza far violenza a nessuno, senza provocare nessuno: “Perché scelgo io d’indossarlo, come altre ragazze e donne”» (Cardini: 15).
Sulla stessa linea d’onda si pone la riflessione della Iannucci, che del velo sottolinea il suo valore di abito aderente a quei valori della pudicizia e del rispetto propri dell’Islam:
«Ciò che chiamiamo velo in realtà è uno stile di vita, molto più di un abito, e va letto in un sistema di comportamento e relazione tra uomini e donne improntato al pudore e alla riservatezza reciproci, ad un sistema di valori proprio dell’Islam. Si può dedurre dagli ahadith come il velarsi sia stato compreso fin dagli inizi dalle donne musulmane come un atto di obbedienza a Dio e non ai loro uomini, e fu all’epoca una libera accettazione da parte delle donne di ciò che il Corano prescriveva loro» ( Iannucci: 112).
È evidente che il tema del velo richiederebbe uno spazio di discussione impossibile da esaurire in poche pagine. Tuttavia, è possibile avanzare delle riserve su alcune affermazioni dei due studiosi che non convincono del tutto e che rischiano invece di apparire come un giustificazionismo a priori di certe posizioni. Si veda, ad esempio, l’argomentare di Cardini intorno al velo inteso come strumento di libertà:
«Oggi, nel libero e felice Occidente, si è giunti beatamente all’eccesso opposto, alla follia contraria: una donna o una ragazza è obbligata all’impudicizia, condannata all’impudicizia. La libertà di mostrarsi e di scoprirsi è andata mutandosi in obbligo. (…) È giusto e naturale tutto ciò? È davvero conditio sine qua non di libertà? Non è invece una desolante manifestazione di conformismo, di adesione acritica o vile al “pensiero unico”? E il confronto con una musulmana che indossa con dignitosa modestia il suo hijab non può farci riflettere? Potrebbe rappresentare non già un “caso” di “repressione” e di “regressione”, bensì di alta e autentica libertà? » (Cardini: 16).
Per quanto desolante, acritica o vile (!), la decisione di una donna se aderire o meno al “pensiero unico” è sua e solo sua. Se la stella polare di una discussione seria sul velo deve essere la sola libertà delle donne, allora tali paralleli tra la pudicizia dell’hijab e la volgarità degli abiti occidentali portano la discussione su un piano differente.
La posizione di Cardini trova comunque una sponda in alcuni movimenti femministi del mondo musulmano, che ritengono il velo
«come espressione di un diritto della donna a coprire il suo corpo, a sottrarlo allo sguardo maschile, che ha modellato una società in cui le donne sono molto presenti ma hanno poco potere (…). A questo modello si oppone la scelta del pudore che diviene rivoluzionaria» (Iannucci: 113).
Ma allora, si potrebbe obiettare, come interpretare gesti come quelli di Huda Sharawi (1879-1947) e di tutte quelle donne che, con rischi altissimi per la propria incolumità fisica, decidono di non portare più il velo islamico? Non sarebbe quanto meno irrispettoso parlare loro di viltà o di conservatorismo rispetto alla “rivoluzione del pudore”? E che dire di quelle nazioni in cui partiti conservatori (è il caso della Turchia) si muovono affinché ritorni obbligatorio l’hijab? Sono domande che occorre farsi per non fermarsi a quello che potremmo definire l’academically correct, che non aiuta un approccio oggettivo e neutrale alle difficoltà poste dal velo islamico, spesso per paura di incomprensioni su un tema che, come si è visto, non ha smesso di destare polemiche.
In conclusione, si è detto precedentemente che la stella polare di ogni discorso sul velo dovrebbe essere la libertà delle donne. Accogliendo questa premessa, ne deriva che l’«alta e più autentica libertà» non corrisponde allo scegliere l’hijab contro la desolazione occidentale, ma alla possibilità di sceglierlo o meno, senza alcuna costrizione, senza alcun patriarcato latente, senza alcun giudizio morale pronto a scendere sulle loro teste, siano esse velate o meno.
Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018
Note
[1] Si rimane abbastanza perplessi nel trovare, in un testo composto da articoli scritti da riconosciuti e attenti studiosi, estratti e citazioni di livello infimo e grottesco. In particolare, la lunga citazione del “giornalista” Facci, riportata nell’articolo di Moual, è forse eccessiva. Se questa è sicuramente utile nel dare un’idea immediata dello squallore di certa stampa italiana e dell’inconsistenza di pensiero dei suoi protagonisti, allo stesso tempo espone i lettori al rischio di accettare come interlocutori, come posizioni sensate ciò che sensato non è affatto. L’insensato trova già troppo spazio nel chiacchiericcio stantio e fazioso di giornali e trasmissioni televisive, con conseguenze disastrose sul tessuto sociale. Sarebbe forse stato abbondantemente sufficiente citare qualche titolo della testata per cui scrive Facci, per comprendere l’abisso in cui è sprofondata una certa retorica contraria all’integrazione e all’immigrazione.
[2] Sigla della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, con sede a Bologna.
[3] Sul ritorno del religioso nel mondo contemporaneo, un’analisi interessante è presente in G. Kepel, La rivincita di Dio, Rizzoli, 1991.
[4] Si veda il caso francese, dove con la legge 228/2004 si è proibito l’ingresso a scuola delle ragazze musulmane in hijab, provocando un enorme dibattito fuori e all’interno delle istituzioni.
[5] Il libro a cui si fa riferimento è Fatihi, C., Non ci avrete mai. Lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi, Rizzoli, Milano 2016, dal discreto successo editoriale.
Riferimeni bibliografici
Fatihi, C., Non ci avrete mai. Lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi, Rizzoli, Milano 2016
Kepel G., La rivincita di Dio, Rizzoli, Milano 1991
__________________________________________________________________________
Roberto Cascio, laurea Magistrale in Scienze Filosofiche conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, con una tesi dal titolo “Le Pietre Miliari di Sayyid Qutb. L’Islam tra fondamento e fondamentalismo”. Ha collaborato con la rivista Mediterranean Society Sights ed il suo campo di ricerca è l’islamismo radicale nei Paesi arabi, con particolare riferimento all’Egitto.
__________________________________________________________________________